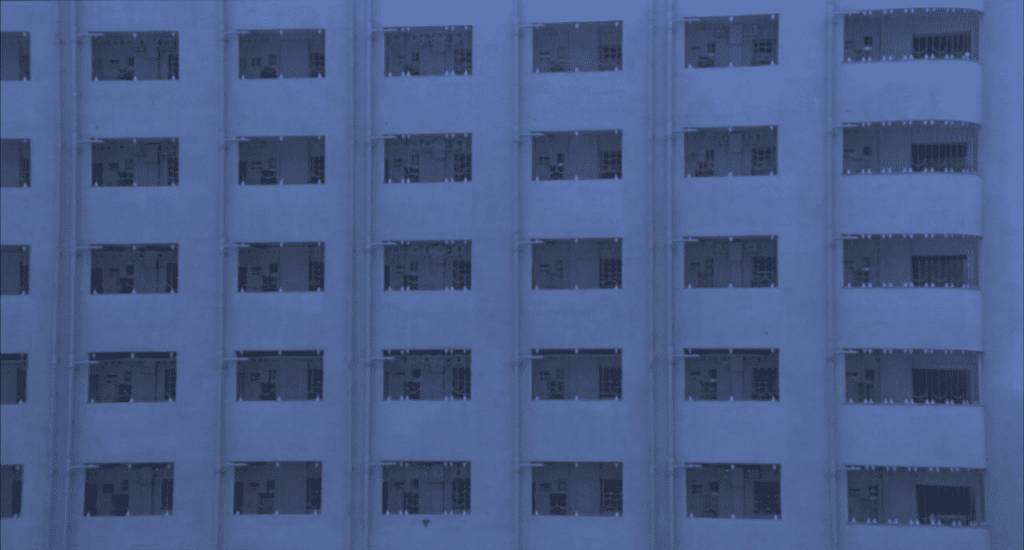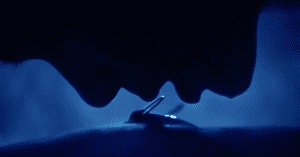I cineasti orientali, si sa, si contraddistinguono per l’elevata sensibilità artistica e per la cura dell’estetica che gli permettono di analizzare l’essere umano a 360°, desideri, paure, pulsioni, squilibri esistenziali e chi più ne ha più ne metta, il ventaglio delle emozioni viene scandagliato completamente, in un modo di fare cinema che esula dal modello occidentale contemporaneo e che sembra quasi appartenere ad un’altra epoca. Shin’ya Tsukamoto è un regista giapponese che, influenzato da David Cronenberg, è interessato a tematiche quali: l’alienazione, l’identità, la violenza e la trasformazione del corpo. Tokyo Fist (1995) è il suo masterpiece totale.
“In Giappone non esiste violenza nella vita quotidiana. I film americani sono violenti e realistici perché in America un ragazzino può benissimo prendere una pistola, andare a scuola e sparare ai compagni. Questo non accade in Giappone dove la violenza è sistematicamente rimossa.Gli impiegati giapponesi si alzano alla mattina, salgono su un treno affollatissimo, viaggiano schiacciati uno all’altro. Vanno in ufficio e si inchinano al capo per otto, dieci ore. Poi tornano a casa e si inchinano alla moglie. Ora dopo ora, accumulano un’incredibile quantità di rabbia, eppure la loro violenza è sempre trattenuta. Solo il dolore ci rende coscienti di avere un corpo” (Shin’ya Tsukamoto, 1995)
Indice dell'articolo
Stile ed estetica
Tsukamoto ha plasmato il suo stile e la sua regia sperimentale sin dai primi cortometraggi, conferendogli dei tratti distintivi facilmente riconoscibili in tutte le sue opere e specialmente in Tokyo Fist: l’uso massiccio della steadicam, le inquadrature frenetiche che non lasciano riprendere fiato allo spettatore, il montaggio convulso unito ad una colonna sonora punk ossessiva, l’utilizzo di filtri cromatici ed infine una buona dose di violenza.
La metropoli e lo stress
La crisi dell’uomo moderno è una crisi interiore che affonda le sue radici nell’ambiente che oggigiorno lo circonda e lo schiaccia sempre di più: la metropoli. Quest’ultima annichilisce le esistenze quotidiane condannando gli uomini a vite fatte di rinunce e repressioni, a rassegnarsi alle maschere sociali che il gioco dei ruoli gli ha assegnato obbligandoli ad indossarle per sempre, senza possibilità di cambiare questo amaro destino. Il film narra le vicende di Hizuru e Tsuda, una giovane coppia in crisi sentimentale, ben presto però il precario equilibrio che li tieni uniti viene minato dall’arrivo di Kojima, un ex compagno di liceo di Tsuda. I protagonisti di questo triangolo amoroso sono accomunati da uno stile di vita insoddisfacente e monotono, dall’insostenibilità dei pesanti e stressanti ritmi lavorativi dettati dalla metropoli. A far da sfondo alle vicende dei tre è proprio una grande metropoli, Tokyo, con i suoi grattacieli che sfiorano il cielo e che ti fanno sentire una nullità in un nulla cosmico.
La fotografia di Tokyo Fist assume un valore altamente simbolico grazie all’utilizzo di un blu monocromo che esprime la freddezza della schematica e rigida geometria degli edifici che ingabbiano gli abitanti in prigioni di cemento dove ciascuno ha il proprio posto assegnato. L’importanza del colore non riguarda solamente le costruzioni ma anche gli individui che li popolano, facendo un parallelo con il mondo dell’arte, le variazioni cromatiche erano spesso legate a differenti emozioni o stati d’animo, il blu veniva, ad esempio, adoperato dagli espressionisti per indicare dolore o tristezza, in Tokyo Fist, invece, le suggestive sequenze dipinte di blu possono riferirsi all’apatia, al senso di vuoto che blocca l’uomo moderno in un circolo vizioso da cui non c’è via d’uscita.
La via d’uscita: la violenza
Lo stress, la pressione (rappresentati visivamente da bruschi movimenti sullo schermo, come terremoti) e la monotonia che intrappolano Hizuru, Tsuda e Kojima in una non-vita danno origine a comportamenti violenti e spesso masochistici. La violenza permetta di prendere atto del proprio stato e diventa l’unica possibilità per liberarsi dalla catalessi di cui si si soffre. Tokyo Fist anticipa nei tempi il concetto che farà da padrone a Fight Club (1999) di David Fincher: il dolore è l’unico modo di sentirsi vivi. Il risveglio non si limita però alla sfera mentale ma coinvolge soprattutto il corpo che diviene materia/carne su cui intervenire per rendere concretamente tangibile il proprio cambiamento, ecco perchè Hizuru comincia a modificare in profondità il suo corpo con piercing sempre più invadenti e tatuaggi, mentre Tsuda, che arriverà a desiderare la morte di Kojima, si sottopone a sfiancanti allenamenti di boxe affinchè possa poi dare con il suo fisico sfogo alle pulsioni omicide. Kojima, da semplice elemento di disturbo, verrà completamente trascinato nel vortice del cambiamento e scoprirà di non essere mai stato abbandonato dai suoi incubi.
Tsukamoto porta all’estremo l’utilizzo della violenza, il gore dilaga, il sangue scorre a zampilli, i visi lasciano spazio a volti tumefatti e deformati che segnano la fine del processo di liberazione dalle scomode maschere della metropoli.
Francesco Stampati